Giancarlo CANUTO
Sconosciuto e inaspettato dono nella Domenica delle Palme mi è giunto da un amico fraterno questo libretto tanto breve quanto “esplosivo” a conferma – per la ennesima volta – che le cose essenziali non hanno bisogno di molte parole o ragionamenti per esprimersi e andare subito al cuore: “Il segno delle chiese vuote per una ripartenza del cristianesimo”, di Tomáš Halík (Edizioni Vita e Pensiero, 2020).
Solo 17 pagine per lasciarsi interrogare, da “cercatori”, se questo periodo drammatico ed intenso di restrizione mondiale possa comunicare qualcosa di “oltre”, di più profondo, in particolare ai credenti per riflettere, e pregare, sulle chiese vuote, specie durante la Settimana Santa, centro e culmine della cristianità.
Non conoscevo Tomáš Halík ed è stata per me una scoperta molto significativa. Sono andato alla ricerca del suo percorso e leggo nel profilo pubblicato dalla Editrice Vita e Pensiero (che cura le pubblicazioni dell’Università Cattolica) che è nato a Praga nel 1948, dopo gli studi in filosofia, sociologia e psicologia, è stato espulso dall’università e perseguitato come nemico del regime comunista cecoslovacco. Ordinato clandestinamente prete, è stato uno dei collaboratori e consiglieri più stretti del presidente Vaclav Havel. Oggi insegna filosofia e sociologia della religione all’Università Carlo di Praga. Per i suoi libri, tradotti in varie lingue, e per il suo impegno a favore del dialogo interreligioso, dei diritti umani, della libertà spirituale, ha ricevuto in patria e all’estero numerosi premi, tra cui nel 2014 il prestigioso Templeton Prize, una sorta di Nobel per la religione[1].
In questo suo ultimo scritto ciò che ho trovato immediatamente vicino al mio sentimento e alla mia riflessione è la comune preoccupazione che una volta riavviato il “play” – dopo questo “stand by” universale – non torni tutto alla normalità. Perché la “normalità” di prima era profondamente “malata” e il fermarsi può costituire una occasione unica per un “nuovo inizio”. In particolare, l’autore, si sofferma sul perché e sul come può essere una occasione per la Chiesa e per i credenti di ripensarsi e darsi una nuova identità più autenticamente evangelica.
Raccogliere questa sfida è saper mettere in pratica la metafora di Papa Francesco che vorrebbe una Chiesa «ospedale da campo». Una Chiesa cioè che abbatte i propri confini e porta aiuto laddove le persone sono fisicamente, mentalmente, socialmente e spiritualmente afflitte. Collocandosi affianco a questa umanità sofferente “la Chiesa può fare penitenza per le ferite inflitte di recente da suoi rappresentanti ai più indifesi”[2]. Una Chiesa che deve continuare a offrire l’assistenza sanitaria, sociale e filantropica come fa’ da sempre ma allargando i suoi compiti: “deve svolgere un ruolo diagnostico (identificando i ‘segni dei tempi’), un ruolo preventivo (creando un ‘sistema immune’ in una società in cui dilagano i virus maligni della paura, dell’odio, del populismo e del nazionalismo) e un ruolo da convalescenziario (superando i traumi del passato con il perdono)”.[3]
L’impulso decisivo a ripensarsi come Chiesa e come comunità può essere proprio cogliere questo “segno” eccezionale delle chiese vuote e trasformarlo in sfida. “Comprendere il linguaggio di Dio negli eventi del nostro mondo richiede l’arte del discernimento spirituale, che a sua volta esige un distacco contemplativo dalle nostre emozioni e dai nostri pregiudizi sempre più forti, oltre che dalle proiezioni delle nostre paure e dei nostri desideri”[4]. In questa azione di riflessione contemplativa il teologo ceko si chiede “se questo tempo di chiese vuote e chiuse non rappresenti una sorta di monito per ciò che potrebbe accadere in un futuro non molto lontano: fra pochi anni esse potrebbero apparire così in gran parte del nostro mondo. Non ne siamo già stati avvertiti più e più volte da quanto è avvenuto in molti Paesi, dove sempre più chiese, monasteri e seminari si sono svuotati o hanno chiuso?”[5]
Segnali che non stati colti preferendo attribuirne la responsabilità più al mutato contesto esterno (lo ‘tsunami secolarista’) che alla difficoltà di saper trovare nuovi e credibili canali di comunicazione.
Andrebbe colto in questa chiusura provocata dall’emergenza sanitaria “il vuoto nascosto delle Chiese, e il loro possibile futuro se non si compie un serio tentativo per mostrare al mondo un volto del cristianesimo completamente diverso. Abbiamo pensato troppo a convertire il ‘mondo’ (il ‘resto’) e meno a convertire noi stessi, che non significa un mero ‘migliorarci’, ma un radicale passaggio da uno statico ‘essere cristiani’ a un dinamico ‘divenire cristiani’”[6].
Accompagnare e sostenere il cammino di riforma di Papa Francesco, della sua Chiesa in uscita, nodo centrale del suo Pontificato ma già dentro la sua esperienza pastorale. Il giorno prima dell’elezione a papa, il cardinale Bergoglio citò un passo dell’Apocalisse in cui Gesù sta alla porta e bussa. E aggiunse: oggi Cristo sta bussando da dentro la Chiesa e vuole uscire.
Una Chiesa in uscita che può trovare la forza per questo slancio proprio in queste ore quando le nostre chiese saranno vuote a Pasqua e si leggeremo i passi del Vangelo sulla tomba vuota da qualche altra parte: “Ma se il vuoto delle chiese ricorda la tomba vuota, non ignoriamo la voce dall’alto: «Non è qui. È risorto. Vi precede in Galilea». Ecco una domanda per stimolare la meditazione in questa strana Pasqua: Dov’è la Galilea di oggi, dove possiamo incontrare il Cristo vivente?”[7]
E qui la intuizione spirituale del dove è la Galilea di oggi trova una indicazione esplicita leggendo le moderne ricerche sociologiche che indicano che nel mondo il numero di quelli che l’autore chiama i ‘residenti’, cioè coloro che s’identificano fino in fondo con la forma tradizionale di religione, ma anche coloro che dichiarano un ateismo dogmatico, è in diminuzione, mentre stanno aumentando i ‘cercatori’. Inoltre, ovviamente, è in aumento il numero degli ‘apatei’, gli indifferenti, persone a cui delle questioni religiose o della risposta tradizionale a esse non importa assolutamente nulla.
Questi dati fanno dire al teologo Tomáš Halík che “la principale linea di divisione non è più fra quanti si considerano credenti e quanti si considerano non credenti. Vi sono ‘cercatori’ fra i credenti (coloro per i quali la fede non è un ‘retaggio’, ma una ‘via’) e fra i non credenti, che respingono i concetti religiosi proposti loro da quanti li circondano, ma provano comunque il desiderio di qualcosa che soddisfi la loro sete di significato. Sono convinto che la ‘Galilea di oggi’, dove dobbiamo cercare Dio, che è sopravvissuto alla morte, sia il mondo dei cercatori.”[8]
Un cambio radicale dell’azione pastorale proposto da Halík che anziché chiedere alle comunità di curare i “residenti”, piuttosto di andare a collocarsi tra i “cercatori”, non solo come è stato detto dalle teologie più avanzate fra le persone ai margini della società ma è necessario cercare Dio anche fra le persone emarginate all’interno della Chiesa, fra ‘coloro che non ci seguono’. Abbandonando obiettivi di proselitismo, non si entra nel mondo per ‘convertirli’ e introdurli nei confini istituzionali e mentali delle nostre Chiese. “Nemmeno Gesù provò a fare rientrare a forza quelle «pecore perdute della casa di Israele» nelle strutture dell’ebraismo dei suoi tempi. Sapeva che il vino nuovo doveva essere versato in otri nuovi”[9].
“Il Signore ha già bussato ‘da dentro’ ed è uscito; il nostro compito è cercarlo e seguirlo. Cristo ha varcato la porta che avevamo chiuso per paura degli altri. Ha attraversato il muro che avevamo eretto attorno a noi. Ha aperto uno spazio la cui ampiezza e la cui profondità ci hanno fatto girare la testa”[10].
È giunto il tempo, conclude il suo intenso scritto Tomáš Halík, per un ecumenismo più ampio, per una più audace ricerca di Dio «in tutte le cose». E questa Quaresima di chiese vuote può essere sfruttata come un momento opportuno per «prendere il largo» e “cercare una nuova identità per il cristianesimo in un mondo che cambia radicalmente sotto i nostri occhi”[11]. L’attuale pandemia non è certamente l’unica minaccia globale per il nostro mondo, ora e in futuro.
“Facciamo dell’avvicinarsi della Pasqua una sfida a cercare nuovamente Cristo. Non cerchiamo il Vivente fra i morti. Mettiamo coraggio e tenacia nel cercarlo, e non lasciamoci prendere alla sprovvista se ci appare come uno straniero. Lo riconosceremo dalle sue ferite, dalla sua voce quando ci parlerà intimamente, dallo Spirito che porta la pace e bandisce la paura.”[12]
9 aprile 2020
[1] Tra i suoi libri tradotti in italiano si trovano:
- Mistica, anima della filosofia?, Fondazione nazionale “Vito Fazio-Allmayer”, Palermo 1999
- Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l’ateismo, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012
- La notte del confessore, Milano, Figlie di San Paolo 2013
- Voglio che tu sia. L’amore dell’altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 2017
- Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano (Anselm Grun & Tomas Halik), Queriniana 2017
[2] Il segno delle Chiese vuote… pag. 9
[3] Idem… pag. 9
[4] Idem… pag. 10
[5] Idem… pag. 10
[6] Idem… pag. 11
[7] Idem… pag. 13
[8] Idem… pag. 14
[9] Idem… pag. 15
[10] Idem… pag. 15
[11] Idem… pag. 17
[12] Idem… pag. 17
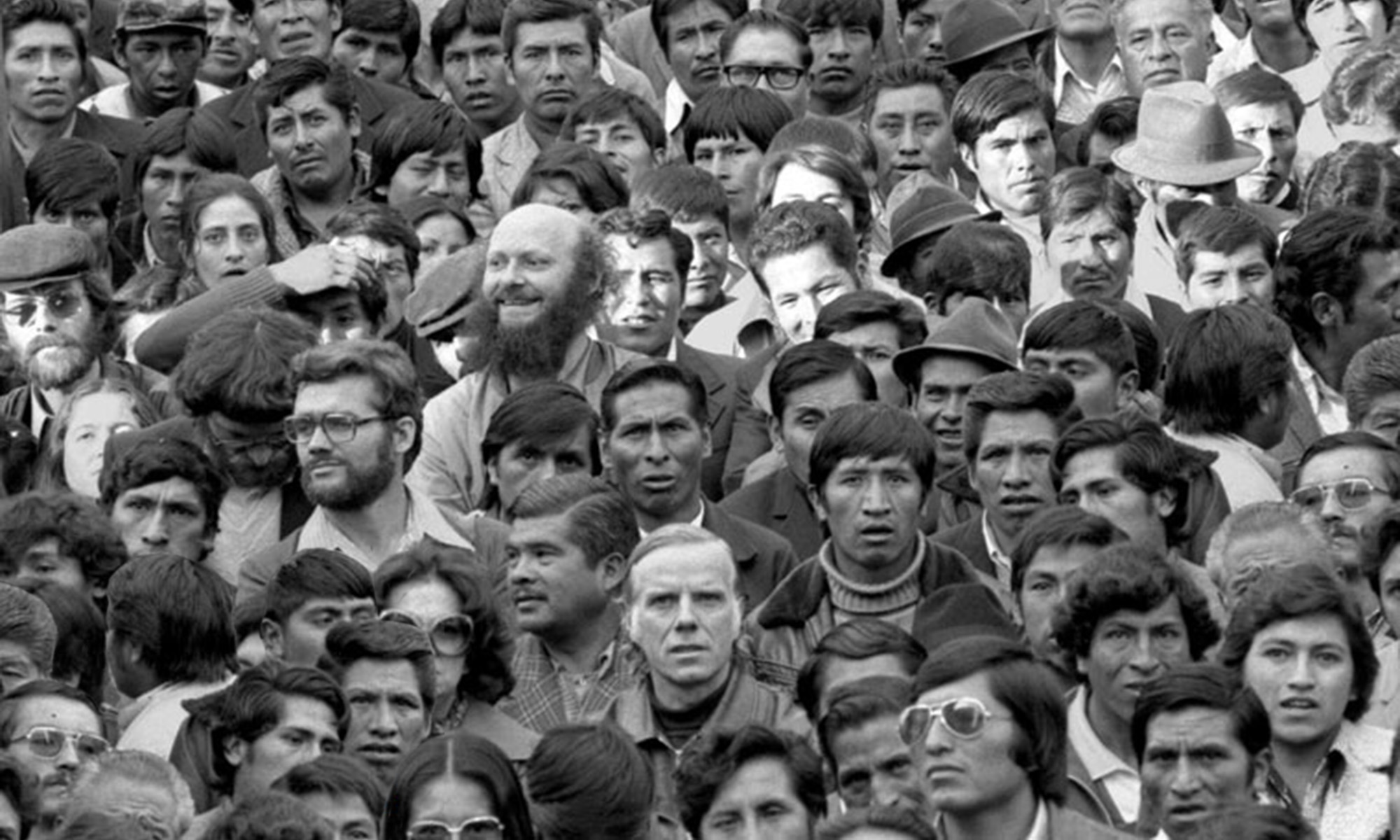
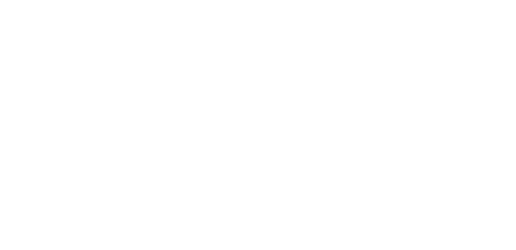
Se torniamo a Cristo saremo degni testimoni del sapere più che delle emotività.
La conoscenza come ripartire convergendo a Cristo. In Cristo troveremo le ragioni tutte del vivere. Un virus ci avrà fatto capire i limiti del mondo, di tutto ciò che concerne il vivere dove la creatura non deve essere offesa. Convivere nel mondo nel rispetto dei doni ricevuti.Il dopo del virus farà risalire e guardare tanti errori commessi nella stravaganza del pensiero universale, senza risolvere le povertà aumentando le ricchezze dei pochi.Il disordine è anche virus veleno, allontanamento e mai comunione.Una chiesa vuota è una casa dimenticata che offre, perchè no, al maligno la gioia della divisione quale suo mestiere.Comunio
ne e mai divisione per offrire ricchezza distribuita alla comunità del mondo come terra unica di intenti e desideri. Il Cristianesimo è umiltà, è intesa è unità di doveri.
"Mi piace""Mi piace"